Riassunto
In questo articolo gli autori vogliono evidenziare la intrinseca relazione tra i concetti di democrazia (nella sua accezione culturale, valoriale e pratica) e di salute mentale, nonché la loro relazione con i concetti di dignità, diritti, partecipazione, felicità.
Gli autori, inoltre, presentano una proposta di integrazione tra quattro approcci terapeutici complementari tra loro nei principi cui si ispirano, e nei quali i valori su citati trovano una efficace declinazione.
Tale proposta, nella attuale fase storica di crisi dei Servizi, sembra la più utile a rilanciare i valori innovativi portati avanti con determinazione da Basaglia, e rappresentare un modo concreto di dare risposte ai bisogni di cura e di benessere dei cittadini.
Introduzione
Democrazia e Salute Mentale sono due beni pregressi e indivisibili. Ci si accorge della loro importanza quando ne siamo privati, quando si perdono o sono a rischio. Con il concetto di democrazia intendiamo una modalità di attuare i processi decisionali fondata sulla condivisione del potere, l’esercizio dei diritti, la giustizia sociale e le sue regole, la libertà di espressione e di comunicazione, la partecipazione, il conflitto finalizzato a trovare soluzioni, la condivisione delle decisioni sulla comunità di vita, la pratica del confronto con l’altro.
In particolare vogliamo sottolineare quest’ultimo concetto, in quanto si fonda su un principio basilare che è la capacità di ascolto, inteso come un dialogo aperto e continuo, fondato sulla consapevolezza della irraggiungibilità dell’“altro”, che è in continuo divenire.
Allo stesso modo intendiamo il concetto di democrazia, come un valore delle relazioni sociali in continua trasformazione, e mai definito in maniera esaustiva. Inoltre riteniamo che non possa esistere un concetto di reale democrazia senza comunità così come non può esistere una comunità effettiva e tangibile senza democrazia. Essa, nella nostra accezione, può riguardare qualsiasi comunità di persone: la comunità locale, le istituzioni, le comunità terapeutiche, ecc.
Delle molteplici forme di democrazia noi considereremo, per la nostra riflessione, la democrazia partecipativa che comprende lo sviluppo di tutti gli strumenti utili a fornire informazioni e a favorire e stimolare la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni di una comunità locale.
Essa è intrinsecamente collegata ai diritti di cittadinanza per tutti i membri di una comunità, ossia l’insieme dei diritti civili, politici e sociali: il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla solidarietà sociale, all’assistenza sanitaria, alle pari opportunità di lavoro e di istruzione, alla casa; il diritto di avere potere decisionale sul proprio corpo, sulla propria salute e sulle cure. Il diritto di esercitare i diritti.
La democrazia partecipativa, così intesa, ci riconnette alle nostre radici antropologiche e culturali, ereditate dalla antica Grecia: in particolare alla Pòlis, come città e forma elettiva di governo politico, e alla Agorà ossia la piazza, luogo di incontro e di scambio nel cuore della Pòlis, dove venivano anticamente prese in modo collettivo le decisioni relative ad essa. La Grecia è stata storicamente la culla della democrazia, della partecipazione e del valore riconosciuto al dià-logos, ossia al confronto verbale che attraversa due persone come strumento per esprimere sentimenti e per discutere idee.
Gli ordinamenti della democrazia tendono a garantire un altro valore essenziale per l’uomo: la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di coscienza. Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne Costituzioni e sancita, per esempio, nell’ art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Essa rimanda anche al valore della dignità come valore intrinseco, status ontologico dell’uomo. «È un sentimento che è chiaramente collegato al riconoscimento di essere prezioso per sé e per il gruppo sociale a cui si appartiene e che si condivide. Sentire di farne parte e di essere inclusi. Etimologicamente è: “qualità di degno” dal latino dignitas che si traduce come “prezioso” e si riferisce al valore intrinseco dell’essere umano in quanto essere razionale, dotato di libertà e potere creativo; perché le persone possono modellare e migliorare la propria vita mediante l’assunzione di decisioni e l’esercizio delle loro libertà» (Palleiro, 2015).
La tutela e la promozione della dignità, insieme agli altri valori sopra citati, è oggi più che mai attuale e necessaria trasversalmente per tutti i cittadini di una comunità. Nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art.1, si sottolinea che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”. Anche la Costituzione Italiana fa esplicito riferimento alla dignità negli articoli 3, 36, 41 ed in particolare nel 32.
I concetti su esposti fondano ciò che contribuisce a garantire il benessere mentale di tutte le persone di ogni comunità, territorio o nazione.
Per ciò che attiene nello specifico alle persone con sofferenza psichica, possiamo fare riferimento anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2006 e resa esecutiva in Italia nel 2009. Attraverso i suoi 50 articoli, la convenzione indica la strada da percorrere per garantire i diritti di eguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità, per tutelarne la dignità.
In particolare l’art. 3 sancisce, tra gli altri principi: a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone; b) La non-discriminazione; c) Il rispetto per la differenza e l’accetta-zione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; d) La parità di opportunità; e) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
Inoltre l’art. 19 sottolinea, per le persone con disabilità, il diritto ad una vita autonoma e alla piena inclusione nella società, il diritto di scegliere il proprio luogo di residenza, di essere inclusi nel libero mercato del lavoro, il diritto all’istruzione, di prendere parte alla vita della comunità in piena integrazione con essa. Ci domandiamo se oggi le persone affette da patologia psichiatrica vedano sempre riconosciuti tali diritti, o se siano nelle condizioni di esercitarli.
Ci domandiamo anche se i Servizi di Salute Mentale, nella accezione più ampia del termine, siano ad oggi organizzati rispettando i principi generali della cultura democratica. La risposta a tali quesiti è tendenzialmente negativa. L’approccio dominante attualmente in ambito sanitario a livello nazionale, e internazionale, è quello biomedico e burocratico, tendente ad una logica prestazionale e parcellizzante piuttosto che comunitaria e capace di considerare la persona nella complessità della propria inter-soggettività e dei propri bisogni di cura.
La risultante è che spesso i Servizi sono organizzati sui bisogni identitari dei professionisti piuttosto che su quelli di cura degli utenti e delle famiglie.
Solitamente gli utenti ed i loro familiari sono costretti ad adattarsi a rigidi standard prestazionali delle varie istituzioni (SPDC, CSM, Centri diurni, ambulatori, Strutture residenziali, ecc.), spesso ricevendo cure farmacologiche non accompagnate da sostegno psicologico continuativo e/o da un vero progetto terapeutico co-costruito e compartecipato. Difficilmente l’utente ha, al di là della forma, libertà sostanziale di scegliere quali cure effettuare, tra le tante opportunità possibili, e dove.
In questo quadro generale si distinguono, tuttavia, alcune eccezioni che costituiscono un possibile modello di buone prassi nel campo della Salute mentale. In questi anni, nella nostra pratica clinica centrata sui gruppi, sulla psicoterapia di comunità, sulla psicoanalisi sociale, svolta in un contesto complesso e a volte difficile, abbiamo cercato ed incontrato colleghi di diverse parti del mondo, affini per stile di lavoro, per cultura e condivisione della pratica clinica e per visione politico-sociale.
Ci riferiamo ad approcci nei quali i principi della democraticità ed il rispetto dei diritti e della dignità delle persone con sofferenza psichica e delle loro famiglie vengono perseguiti e praticati, essendo considerati parte essenziale dello stile di lavoro degli operatori della salute mentale.
Essi sono il Gruppo Multifamiliare (GPMF), l’Open Dialogue (OD), la Comunità Terapeutica Democratica (CTD), l’Inclusione Socio-lavorativa.
I principi fondativi che animano tali dispositivi terapeutici hanno tra loro, come vedremo di seguito, importanti punti di contatto che li rendono significativamente compatibili e complementari nel sostenere i processi di cura delle persone con sofferenza psichica e nel favorire lo sviluppo di Servizi di Salute Mentale democratici, fondati sui principi della partecipazione ai processi decisionali, della co-costruzione condivisa delle buone prassi, della solidarietà, dell’empowerment e del benessere di tutti i soggetti che li attraversano: utenti, familiari, operatori, cittadini della comunità locale…..





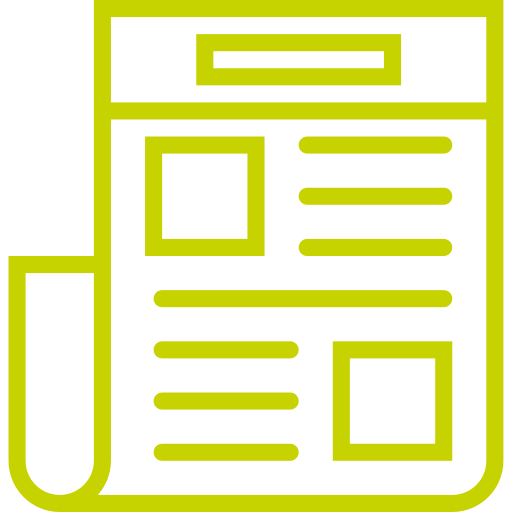

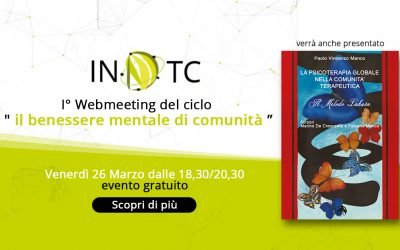





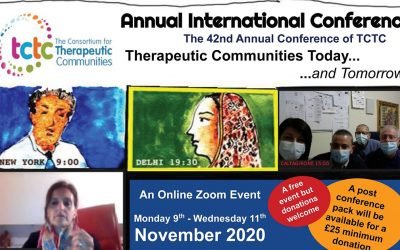
Commenti recenti